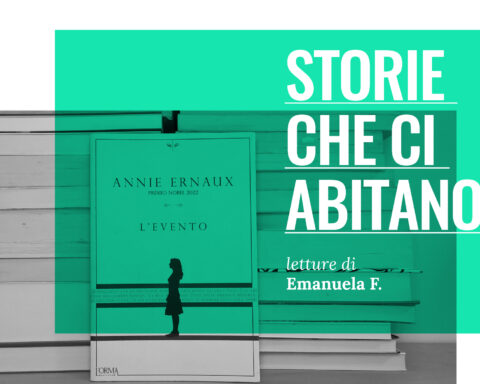Ci piace raccontarci come eredi dei partigiani e nipoti delle streghe che non sono riusciti a bruciare, collocandoci così all’interno di un percorso lineare di progresso ideale. Queste immagini così poetiche spesso però ci portano a dimenticare chi furono veramente i nostri avi e quale fu il ruolo ricoperto da loro, italiani ed europei, nel corso degli ultimi due secoli di storia: secoli in cui si collocano alcuni dei più alti vertici di barbarie mai raggiunte dall’uomo quali il nazifascismo e l’imperialismo.
L’Unità d’Italia risale al 1861 e poco più di sette anni dopo, nel 1869, la società Rubattino di Genova acquista la Baia di Assab. Nel 1946 l’Italia diviene una Repubblica, l’anno dopo il Trattato di Parigi sancisce la perdita di tutte le colonie italiane eccetto la Somalia e lo stesso anno viene promulgata la Costituzione; è solo nel 1960, “l’anno dell’Africa”, che la bandiera italiana cessa di sventolare su Mogadiscio.
Rielaborazione storica

Facendo due conti l’Italia è stata più a lungo una potenza coloniale che una repubblica. Nella nostra autonarrazione, però, ci piace l’immagine degli “Italiani brava gente” e ci dimentichiamo di questa parte della nostra storia – come pure delle vicende del nazifascismo – ed anche gli altri Paesi europei, che pure hanno fatto più di noi i conti con il periodo della Seconda Guerra Mondiale, poco hanno fatto per quanto concerne la rielaborazione storica del colonialismo.
Basti pensare alla scelta di celebrare la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, a ricordo di tutte le vittime delle migrazioni, il 3 ottobre, data scelta perché in quel giorno del 2013 in un naufragio a largo di Lampedusa persero la vita 368 migranti (in gran parte provenienti da ex colonie italiane, aspetto che però passa sottotraccia).
La nostra incapacità nel cogliere le cause remote dei flussi migratori e nell’ammettere le nostre colpe coloniali è tale che, nell’istituire questa ricorrenza, neppure ci siamo accorti che, per uno strano scherzo del destino, la data scelta coincide con quella in cui nel 1935 le truppe guidate dal generale Emilio De Bono invasero l’Etiopia.
Il mio bisnonno ha partecipato alla guerra in Etiopia del 1935-36. Il mio bisnonno era un colonialista.
Di questa vicenda di storia familiare che si intreccia con la Storia resta un album di poco più di 200 fotografie coloniali che ritraggono monumenti e panorami fra Asmara e Axum, edifici coloniali italiani, animali selvaggi e popolazioni locali; ogni immagine è corredata da un’etichettina recante una didascalia:
“eleganze abissine”, “Asmara – comando truppe”, “Asmara – circolo ufficiali”, “ragazza Bilena”, “ragazze Cunama”, “Beni Amer”, “fantasia di ragazze musulmane”, “gustando il caffè”, “abbigliamenti di preti abissini”, “Zad Amba – Monte Bianco eritreo”, una foto di Ascari reca il titolo “i fedelissimi”.
Non c’è un’organizzazione tematica o geografica nella disposizione delle foto, che si susseguono in ordine sparso e concorrono a creare un immaginario esotico ma al contempo nostrano: quello che si nota è uno sguardo coloniale, si tratta probabilmente di un album di foto ricordo realizzato per essere venduto a soldati italiani di stanza nel corno d’Africa. Emerge anche una certa conoscenza antropologica delle etnie locali ma non dobbiamo dimenticare che all’epoca il confine fra interesse antropologico e razzismo biologico era labile, pur trattandosi di un prodotto precedente al regio decreto del 1937 circa le “Sanzioni per i rapporti d’indole coniugale fra cittadini e sudditi”.
Delle tante foto che ritraggono persone solo due recano un nome proprio: Ariel, un giovane che posa fra le antilopi appese a testa in giù pronte da macellare, e Cantibai Osman Edad, un uomo anziano elegantemente abbigliato (Cantibai è un titolo onorifico).
Questa penuria tanto ci dice su come noi italiani ci ponessimo nei confronti delle identità singole delle persone appartenenti ai popoli colonizzati. Numerose sono le foto di animali esotici, di edifici sia coloniali sia locali e di monumenti, fra essi si nota una foto della stele di Axum prima che venisse trasportata in Italia.
Riflettere sul colonialismo italiano
Del colonialismo, come di tanti altri momenti storici le cui conseguenze sono ancora attuali, a scuola non si parla quasi per nulla. Sono dovuta arrivare all’esame universitario di Storia Contemporanea perché fosse uno fra tanti possibili argomenti di approfondimento a scelta (ma era anche l’anniversario della Grande Guerra e io scelsi saggi inerenti a questo tema).
In una lezione del corso magistrale di storia si parlò delle vicende della stele di Axum, restituita all’Etiopia all’inizio degli anni duemila, e di come mancasse una rielaborazione storica della vicenda; infatti nella piazza di Roma in cui era collocata non si è pensato di porre, per esempio, un monumento alle vittime del colonialismo italiano o pannelli sulla storia della stele stessa ma vi svettano oggi due colonne che ricordano le vittime degli attentati alle Torri Gemelle, una scelta che ignora completamente la precedente sistemazione della piazza e le vicende storiche ad essa connesse.
Il primo prodotto culturale a farmi riflettere sul colonialismo italiano problematizzandone la memoria storica è stato lo spettacolo Acqua di Colonia della compagnia Frosini/Timpano andato in scena per la prima volta nel 2017, la cui sinossi recita:
«Uno spettacolo sul colonialismo italiano. Il colonialismo italiano. Una storia rimossa e negata, che dura 60 anni, inizia già nell’Ottocento, ma che nell’immaginario comune si riduce ai 5 anni dell’Impero Fascista. Cose sporche sotto il tappetino, tanto erano altri tempi, non eravamo noi, chi se ne importa. È acqua passata, acqua di colonia, cosa c’entra col presente? Eppure ci è rimasta addosso come carta moschicida, in frasi fatte, luoghi comuni, nel nostro stesso sguardo. Vista dall’Italia, l’Africa è tutta uguale, astratta e misteriosa come la immaginavano nell’Ottocento; Somalia, Libia, Eritrea, Etiopia sono nomi, non paesi reali, e comunque “noi” con “loro” non c’entriamo niente; gli africani stessi sono tutti uguali.
E i profughi, i migranti che oggi ci troviamo intorno, sull’autobus, per strada, anche loro sono astratti, immagini, corpi, identità la cui esistenza è irreale: non riusciamo a giustificarli nel nostro presente. Come un vecchio incubo che ritorna, incomprensibile, che ci piomba addosso come un macigno.»
Che ambaradàn!
Pur fingendo di dimenticarci del colonialismo italiano continua a fare capolino nel nostro lessico: “che ambaradàn!” per indicare una situazione caotica: è un’espressione che fa riferimento al massacro di Amba Aradam in cui le truppe italiane di Badoglio fecero ricorso alle armi chimiche, il cui uso era già all’epoca vietato dalla Convenzione dell’Aia; “chi ti credi di essere? La principessa Taitù?” si riferisce all’imperatrice Taitù Batùl, moglie del Negus Menelik II, che sconfisse le truppe italiane ad Adua nel 1896.
Ovviamente tutto questo è profondamente problematico ed è necessaria una rielaborazione storica che ci permetta di superare gli strascichi del colonialismo presenti nel nostro linguaggio e dunque ancor più radicati nella nostra mentalità.
Negli ultimi anni si è iniziato a parlare di decolonizzazione culturale, concetto che non riguarda solo dibattiti fra intellettuali ma ha anche risvolti pratici i più noti dei quali hanno a che fare con monumenti dedicati a personaggi implicati nel colonialismo, in Italia è il caso della statua di Indro Montanelli a Milano. Ovviamente ci si augura che questa elaborazione concettuale abbia anche conseguenze reali nella vita delle persone razzializzate.
Decolonizzazione dei musei
Fra gli ambiti interessati da questo processo, significativo è quello dei musei etnografici le cui collezioni sono spesso di origine coloniale o missionaria (la differenza fra le due è in questo caso labile). Le riflessioni contenute in questo articolo sono il frutto della recente visita a due di questi che stanno cercando di mettere in atto un processo di decolonizzazione delle loro esposizioni, a partire dalla loro stessa denominazione, non più di museo etnografico ma di museo delle culture: si tratta del Mudec di Milano e di Castello d’Albertis Museo delle Culture del Mondo a Genova.
Castello d’Albertis è da sempre attento a coinvolgere le popolazioni i cui oggetti sono esposti nel museo ed è stato protagonista di restituzioni di manufatti provenienti dall’Ecuador già nel 2014, prima che diventasse un tema caldo per via di quelle effettuate al Benin dal Musée du quai Branly di Parigi.
Il Museo delle Culture del Mondo di Castello d’Albertis ci consente di fare un’accurata riflessione sull’evoluzione del nostro rapporto con l’alterità culturale attraverso il suo allestimento che si compone per metà della dimora del Capitano Enrico Alberto d’Albertis “tra camere delle meraviglie, suggestioni marinaresche, evocazioni colombiane e trofei coloniali” che rispecchiano la mentalità di un viaggiatore vissuto a cavallo fra Otto e Novecento e la sua visione delle altre popolazioni, figlia del colonialismo, mentre l’altra metà del museo è allestita secondo le più moderne riflessioni in ambito antropologico, museografico e di decolonizzazione del museo, creando così un netto contrasto che ci mostra il cambio di paradigma in atto.
L’interculturalità è al centro di questi moderni musei che hanno spesso come interlocutori le comunità internazionali presenti sul territorio che dialogano con l’istituzione museale.
È questo il caso delle mostre del ciclo Milano Città Mondo del Mudec che in ogni edizione ha come protagonista una diversa comunità a partire da quella eritrea ed etiope, direttamente legata alle vicende coloniali italiane, per poi passare a quella egiziana, peruviana, cinese ed altre nelle edizioni future.
Il Mudec ha da pochi mesi riaperto la sua collezione permanente con un riallestimento dal titolo “Milano globale. Il mondo visto da qui”: all’interno del nuovo allestimento è presente uno schermo interattivo attraverso cui “intervistare” milanesi di origine diasporica facendosene raccontare le storie.
Il museo si compone di cinque sezioni che riescono a farci fare al contempo un viaggio nello spazio e uno nel tempo, a partire dalle prime conquiste nelle Americhe nel XVI-XVII secolo, per poi passare ai rapporti commerciali con l’Asia e alla moda delle cineserie nel XVIII secolo e infine all’imperialismo in Africa fra Otto e Novecento.
La quarta sezione invece si rivolge ad artisti che offrono il loro punto di vista su temi legati al colonialismo e alle migrazioni come l’installazione di Cristina Donati Meyer che problematizza la presenza di un monumento a Indro Montanelli nel parco pubblico a lui intitolato a Milano mettendola in relazione con la sposa bambina che ebbe durante la Campagna d’Africa.
La dodicenne di etnia bilena, forse di nome Fatima o Destà, è rappresentata da una bambola in braccio alla riproduzione della statua che ritrae il giornalista, di fronte ad essa una proiezione dell’intervista in cui lui normalizza il suo comportamento, un comportamento che se tenuto in Europa anziché nelle colonie sarebbe rientrato a pieno titolo nello stupro e nella pedofilia.
Nell’ultima sezione trovano posto opere di artisti afroitaliani contemporanei che riguardano la loro identità, ne è un esempio la canzone #Afroitaliano del rapper Tommy Kuti, una delicata e profonda poesia d’amore per la sua patria d’elezione nonostante le difficoltà incontrate da un italiano di origine straniera e per giunta con la pelle nera.
E’ previsto che le opere esposte in queste ultime sezioni della mostra possano essere aggiornate dopo due anni, coinvolgendo sempre più voci.
Una nuova narrazione
L’attenzione a decolonizzare il museo si nota non solo nel coinvolgimento di interlocutori di origine straniera ma anche da attenzioni nel testo dei pannelli come l’uso delle lingue e dei caratteri originali per le citazioni di inca, cinesi e abissini così come per i nomi in lingua dei manufatti esposti e dei vari gruppi etnici (che sostituiscono termini generici, desueti e di matrice coloniale come indiani d’America, indigeni o simili) e ancor di più per il ricorso ad una narrazione nella quale appare evidente che i colonizzatori non sono portatori di civiltà ma di efferatezze e di genocidi, termini che sono ben lungi dal comparire nelle didascalie più datate di analoghi musei.
Una delle scelte di allestimento che più mi ha convinta è stata quella di esporre due cartoline a faccia in giù, in modo che se ne veda il retro ma non quello che vi è raffigurato ovvero, come riporta la didascalia:
“giovanissime donne, ragazzine, bambine africane sempre a seno nudo ad uso e consumo dello sguardo maschile bianco in un nuovo revival del porno tropic tradition, sono una tipica produzione del periodo coloniale”.
Il pensiero va a quelle donne di etnia Bilen che, dall’album del mio bisnonno, mi guardano con l’espressione dura che, quasi un secolo fa, dovevano aver rivolto ad un ignoto fotografo italiano dallo sguardo oggettificante ed esotizzante.
La scelta di esporre in questo modo tali cartoline è frutto del confronto delle curatrici e del comitato scientifico con le comunità diasporiche ed ha lo scopo di sottrarre le ragazze fotografate alla violenza di ulteriori sguardi, senza però rinunciare a presentarci “uno degli aspetti più spregevoli, rimossi e negati del colonialismo italiano”.
Questo aspetto è centrale anche nella mostra di Castello d’Albertis “Colazione a Melbourne e pranzo a Yokohama”, nella quale ampio spazio è dato alla problematizzazione delle fotografie di matrice coloniale che ritraggono persone appartenenti a popolazioni aborigene australiane (anche in questo caso sono specificati i nomi dei gruppi di appartenenza).
Le didascalie ci pongono domande dirette quali:
“Come ti sentiresti all’interno di un simile set fotografico? Se ci fossi tu in una simile fotografia costruita, come credi che verresti esotizzato/stereotipato? Come ti sentiresti se scoprissi che ci sono fotografie di tua madre, di tuo padre o dei tuoi nonni conservate lontano da casa, nell’archivio di una istituzione culturale? Cosa proveresti se il nome dei tuoi antenati e le informazioni che dovrebbero contestualizzare queste immagini fossero incomplete, errate o razziste?”
Spingendoci così ad empatizzare con il ritrattato e facendoci riflettere su come queste foto non ritraessero la realtà ma ricalcassero la visione stereotipata che gli europei avevano degli aborigeni australiani, di come l’identità del soggetto non sia centrale nell’immagine e di come la presenza di queste immagini in un museo dall’altra parte del mondo possa spesso non essere rispettosa della cultura di chi vi è ritratto.


La mostra, che ha al centro queste riflessioni più che gli oggetti esposti, parte dall’albo di ricordi di viaggio raccolti dal Capitano d’Albertis durante il suo giro del mondo iniziato nel 1877, dai suoi trofei coloniali e dalle fotografie da lui acquistate dal fotografo tedesco di stanza a Melbourne J.W. Lindt con pittoreschi paesaggi australiani e ritratti di aborigeni creati in studio in un set fittizio e stereotipato, non oggettive e neutrali ma frutto di un sistema di potere.
I pannelli in mostra sottolineano come fra Otto e Novecento gli albi di fotografie fossero strumento e segno di appropriazione culturale, usati come mezzo per classificare l’altro, stabilire relazioni di potere e creare stereotipi, prodotto di un contesto in cui antropologia e colonialismo si mescolano inestricabilmente e in cui gli Aborigeni erano considerati il primo gradino dell’evoluzione umana.
Anche in questa mostra trova spazio l’idea di passare il microfono alle popolazioni rappresentate dagli oggetti in mostra ed è pertanto stata interpellata Marika Duczynski, aborigena del gruppo Gamilaraay, oltre che la ricercatrice dell’Istituto per l’educazione e la Ricerca Indigena Jumbunna dell’Università di Tecnologia di Sidney Monica Galassi che ha creato Archivi Aborigeni in Italia il cui scopo è quello di rendere accessibili alle popolazioni Aborigene la documentazione sui loro avi e sulle loro culture presente in alcuni musei etnografici europei e per ricostruire la storia coloniale del paese che oggi chiamiamo Australia.
Nominare un luogo significa possederlo
Del suo intervento mi ha colpito, fra le altre cose, il fatto che non parli di Australia, ma del paese che oggi chiamiamo così, sottolineando quindi come i luoghi esistessero prima della “scoperta” da parte degli europei e avessero già loro nomi nelle lingue locali, poi sostituiti da altri scelti dai colonizzatori perché nominare è un’azione che implica possesso.
Il nominare è un altro tema centrale nel processo di decolonizzazione, come dimostra il fatto che Deb Haaland, prima nativa a ricoprire il ruolo di segretaria dell’interno degli USA, ha creato una commissione il cui compito è quello di individuare toponimi offensivi da modificare, come “negro” e “squaw”.
Nominare un luogo significa possederlo, fare tabula rasa di ciò che eventualmente poteva esserci prima, portare la propria cultura e imporla, e ciò è ancor più evidente quando i luoghi colonizzati vengono ribattezzati con il nome di “Nuovo” seguito dalla propria area di provenienza, ad esempio uno degli stati australiani si chiama Nuovo Galles del Sud, o anche la Nuova Zelanda oggi ben più nota della “vecchia” Zelanda nei Paesi Bassi.
L’assurdità della nostra geografia di matrice coloniale appare evidente se si confronta una cartina politica dell’Australia, composta da sei Stati i cui confini sono delle linee rette, con una mappa delle popolazioni aborigene in cui si vede come il territorio sia diviso in centinaia di gruppi tribali.
E anche la proiezione di Mercatore comunemente adottata nella cartografia non è una rappresentazione oggettiva del mondo ma è figlia dell’eurocentrismo tanto che l’Europa si trova arbitrariamente letteralmente al centro e che le terre emerse più vicine ai poli sono deformate ed appaiono più grandi di quanto non siano in realtà, col risultato che noi finiamo per sottostimare la reale estensione di Africa e Sud America e a sovrastimare quella di Europa e Nord America.

Tutte queste riflessioni sparse non grattano che la superficie del problema, ma vogliono essere uno spunto di riflessione che contribuisca alla decolonizzazione culturale, un processo in fieri, un processo nel quale noi, eredi di popoli colonizzatori, non possiamo che fare la nostra parte innanzitutto ammettendo l’esistenza di questi problemi in noi, nella nostre culture e nelle nostre società per poi cercare di decostruire concetti di matrice coloniale e soprattutto lasciare spazio ai diretti interessati cioè alle persone razzializzate.
Immagine di copertina:
Foto di Redcharlie
Scrivi all’Autorə
Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?
Clicca sul pulsante qui a destra.